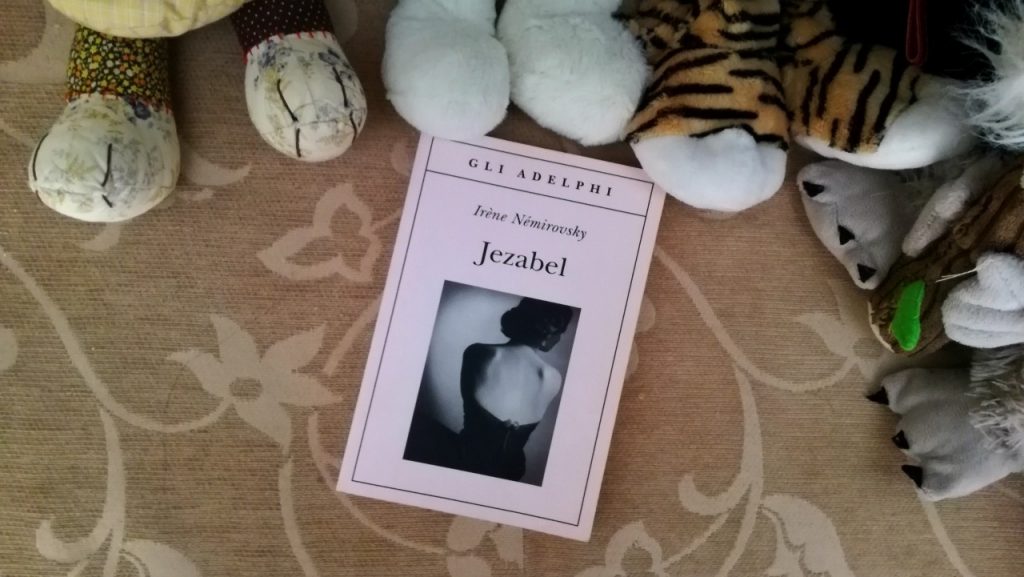Io non mi chiamo Miriam, Majgull Axelsson (Iperporea): la storia di Malika, rinchiusa nei lager perché rom, sopravvissuta grazie a uno scambio d’identità.
Io non mi chiamo Miriam non è l’ennesimo libro sul genocidio: il libro dà voce alle persone a cui meno pensiamo, quando rivolgiamo il nostro pensiero al delirio nazista. Quando pensiamo ai lager, nel 90% dei casi pensiamo alla drammatica sorte degli ebrei. In realtà, fin troppo spesso dimentichiamo che il piano diabolico dei nazisti non si limitava a prevedere l’eliminazione degli ebrei, ma di chiunque fosse considerato di razza inferiore e/o elemento di disturbo all’interno di una società ideale. E la società ideale nazista era fatta di esseri puri e forti: omosessuali, anziani, disabili e rom non ne avrebbero mai fatto parte. Lo sterminio è conseguenza “logica” di tutto questo.
Io non mi chiamo Miriam
Io non mi chiamo Miriam: da rom a ebrea
Io non mi chiamo Miriam narra la vicenda personale di Malika, che viene deportata nei campi di concentramento, assieme alla sua famiglia: è una ragazza rom. Nei lager, Malika perde tutte le persone a lei care; quando viene trasferita da Auschwitz a Ravensbrück, si trova a indossare letteralmente i panni di una ragazza ebrea, non sopravvissuta al viaggio. Da questo momento in poi smette per tutti di essere Malika e comincia a vivere da Miriam. L’esperienza tremenda nel lager non è fatale per Miriam, che arriva in Svezia e là resta per il resto della sua vita. In questo paese ricco e tranquillo, Miriam entra a far parte di una famiglia benestante, ma sempre celando dentro di sé un segreto: lei non è Miriam l’ebrea, bensì Malika la rom.
Io non mi chiamo Miriam è un bel romanzo, corposo. La storia di Malika/Miriam viene presentata al lettore sotto forma di un racconto verbale di Miriam stessa a sua nipote Camilla, in un susseguirsi di ricordi e flashback. Nella prima parte del romanzo, familiarizziamo con nomi e veniamo a conoscenza, seppur succinta, di vari episodi. Sono i pezzi di un puzzle, che viene poi ricostruito poco alla volta nella seconda parte del libro, decisamente la più interessante. Qui scopriamo anche maggiori dettagli della sorte di Didi e Anuscha, della fine di tutti i rom rinchiusi ad Auschwitz, dello stato delle cose del campo di Ravensbrück*
I rom nei lager nazisti
Io non mi chiamo Miriam è un libro che ho apprezzato molto, in particolar modo nella seconda parte del libro, che narra in modo più organico la storia di Miriam. Orrore e disgusto provati durante la lettura non hanno vinto la mia curiosità. Arrivata a un certo punto, ho iniziato a divorare le pagine, per giungere alla fine del romanzo, sul quale sento di spendere due parole.
Non mi metto a ragionare sul fatto storico in sé; tutti abbiamo ragionato abbastanza, così tanto che ormai c’è gente in giro che va dicendo che non è stato vero niente – le camere a gas? mai esistite!
Preferisco pensare a quel che accade oggi, nel nostro quotidiano. Quando ho scritto che Io non mi chiamo Miriam non riguarda strettamente gli ebrei è perché così è. Malika si trova a essere Miriam per caso: finge di essere ebrea per tutto il resto della vita. Si vede costretta a farlo, perché fino a poco prima era stata rinchiusa nel campo con tutti gli altri rom, ma quando si ritrova mescolata alle altre prigioniere, si rende conto di un fatto: i tedeschi odiano gli ebrei, ma tutti gli altri odiano i rom più degli ebrei.
La prigionia è una lotta per la sopravvivenza, a tutti i livelli. I nazisti sono i nemici di tutti, ma nemici sono anche tutti gli altri prigionieri, che si contendono tra loro una patata marcia o un po’ di paglia per il proprio giaciglio. Per Miriam diventa subito evidente che i rom non sono apprezzati da nessuno, così possono resistere solo se fanno gruppo.
Miriam è totalmente sola e non può che continuare a fingersi chi non è. In Svezia nulla cambia: le persone sono disposte ad accettare i sopravvissuti ebrei, ma non vogliono avere a che fare con gli zingari. Non c’è scelta.
Cosa insegna Io non mi chiamo Miriam
Miriam è il chiaro esempio della paradossale lotta tra ultimi e penultimi. Per quanto globalmente mi reputi una persona che non apprezza la presenza dei rom in città, sono abbastanza ipocrita da muovermi a pietà, leggendo il racconto del “bambino della cantina”. Descritto nel libro proprio nelle ultime pagine, è un episodio che mi ha fatto riflettere. Mi stizza la donna che viene a chiedermi soldi, non so se aiuterei un rom in difficoltà , ma sicuramente in linea di massima penso che un bambino è un bambino sempre; una madre preoccupata per suo figlio lo è sempre. E allora il problema qual è? Siamo tutti non razzisti, ma ci sono alcuni che sono non razzisti meno di altri: questo è.
Mentre leggevo le ultime pagine, quelle del pranzo di famiglia, ero un po’ perplessa: perché concentrare l’attenzione sulle incomprensioni tra Camilla e i suoi genitori? Leggendo, mi sono data la risposta da sola: perché è chiaro che, in vecchiaia,
Miriam si rende conto che a causa del pregiudizio ha dovuto fare i conti, costantemente, con il proprio senso di colpa. Miriam si sente colpevole per aver ingannato la propria famiglia e si sente colpevole per aver tradito il suo “popolo”.
Da donna sposata, cerca in ogni occasione di essere la moglie perfetta, l’ebrea di buona famiglia, una persona equilibrata che ricaccia dentro di sé il ricordo dei campi di concentramento. La consapevolezza di non essere mai stata se stessa emerge in tutte la sua forza quando, ormai ultra ottantenne, Miriam prova quasi disgusto nei confronti della mentalità delle persone che l’hanno accolta in Svezia. Non apprezza che non si parli dei campi di concentramento, non apprezza che si debba quasi fare finta che non sia accaduto nulla. Le persone pretendono di vivere come gli struzzi e a Miriam questo non piace: non si può dimenticare e non si può fare finta che la vita non abbia preso una piega ben precisa, soprattutto se si è sopravvissuti.
Proprio perché si è sopravvissuti, non si può tollerare che persone libere, che non hanno nulla da nascondere né da dimenticare, si causino da sole problemi e disagi. Quando ho pensato a questo, i litigi familiari a cui Miriam assiste non sembrano che banalissimi battibecchi: scambio di battute prive di sostanza. La sostanza dei fatti è che se hai visto il Male dritto negli occhi, tutto il resto è nulla: questo per me è il messaggio più significativo che Io non mi chiamo Miriam può trasmettere a chi lo legge.
*Ravensbrück è stato un campo di concentramento prettamente femminile. Al suo interno venivano rinchiuse ebree e rom, ma anche tante donne di origini scandinave e dell’Est. Quest’ultime erano per lo più prigioniere politiche. Secondo recenti studi, Ravensbrück fu il lager in cui si consumarono i peggiori crimini contro le donne.